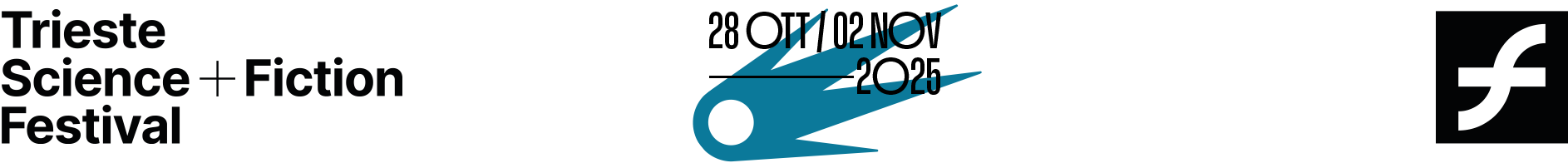Quei viali di luce
Che scorrevano tra le nuvole
Qualche attimo fa sono scomparsi,
Ed improvviso è buio.
Mark Strand
“L’ultima stanza del mondo – Prima parte” di Alex Tonelli
La stanza è fiocamente illuminata. Un alone di luce si diffonde intorno alla lampadina sorretta da un filo nero e consumato che pende dal soffitto scrostato. Tutt’intorno il buio resiste e si annida tra gli oggetti, languendo placido negli spazi. A fatica si intravede un piccolo tavolo, basso e quadrato, esattamente al di sotto della debole lampadina, nel centro della stanza, pare messo lì per un motivo, una ragione condivisa, ormai dimenticata. Sconosciuta.
Lì se ne stanno quattro bicchieri di forme e fattezze diverse, in alcuni pare ancora versato un liquido denso, colloso, di colore viola e intorno delle lattine e una bottiglia di vino senza etichetta. Un posacenere trabocca mozziconi di sigarette piegate e mezzofumate.
L’odore di birra, vino scadente e tabacco ristagna nell’aria e tocca la pelle quasi come una sensazione tattile, appiccicosa, unta.
Si ode un brusio, un bisbiglio, un parlottare fra sé e improvvisamente il rumore di un accendino che s’accende; la fiammella bluastra illumina le fattezze di un uomo per un breve istante, il naso, le labbra che stringono la sigaretta, i baffi cespugliosi, e poi lo sbotto di fumo, biancastro che sale, spiraleggiando, verso l’alto nell’alone sferico della lampadina accesa.
– Smettila di fumare-
La voce femminile arriva dal lato opposto rispetto al punto rosso della brace della sigaretta che in tutta risposta si fa più luminosa e una nuova, nebbiosa, ondata di fumo attraversa la sfera di luce, in onde che si inseguono in spire ritorte.
– Sei uno stronzo! –
Nessuna risposta all’insulto e il silenzio torna a regnare nella stanza.
Il tempo sembra scorrere con una pigrizia strana, trascinando dietro di sé un ricordo, un passato pesante. Un macigno lungo una salita scoscesa.
Un raggio di luce fende l’aria, come una lama di luce, sottile. Pulviscoli di polvere ed altro danzano nello spicchio luminoso e sottile. Altri particolari della stanza si rivelano.
Intorno al tavolo, uno per ogni lato, se ne stanno quattro poltrone, così come i bicchieri anche queste sono scompaginate. Una di pelle strappata, l’altra di stoffa macchiata e un tempo rossa, un’altra ancora semplice struttura di legno senza più la morbida gommapiuma e infine una nuova, talmente nuova da aver ancora il cellophane ad avvolgerla e proteggerla. Su ognuna di queste se ne stanno sedute quattro figure; nella luce debole della sfera e della spada se ne colgono poche fattezze, forse sufficienti però per attribuire loro caratteri umani. Scomposte in pose disarticolate, gettate lì come manichini afflosciati, privi di ogni impudico esibizionismo.
– Un raggio di sole-
Una delle quattro figure sembra un poco muoversi, agitarsi su di una poltrona, quella nuova, ancora avvolta dalla guaina protettiva. La sua voce è carica di una tensione immotivata, come se temesse la daga di luce che da una finestra penetra nella stanza rovinando il delicato equilibrio dell’oscurità. La stessa figura alza una mano vero lo spicchio di luce, muove le dita all’interno del sottile strato luminoso, sfiorando i granelli di polvere che si muovono scomposti. Le dita sono sottili, femminili e, come la sua voce, con l’identica incomprensibile tensione. Uno spasmo improvviso l’attraversa facendola tremare leggermente, sussultare nervosa. La pelle è chiara, se ne intuisce la morbidezza al tatto, la delicatezza del tocco, la capacità di trasmettere emozioni intense. La mano ruota nella luce: il palmo, poi il dorso e, qui, le macchie nere. Cicatrici, forse croste, di un nero intenso, come carne bruciata, cancerosa.
Uno scatto, la mano torna al sicuro nel buio.
– Hai ancora quelle macchie –
– Si. Sono sempre più grandi –
– Ormai ti copriranno tutta –
– Smettila di dirle queste cose!-
– Lo sai anche tu che è la verità. Ha la Malattia e non le resta molto tempo.
– Coglione!
Due voci, crudeli che giocano fra di loro, a prevalere, a imporsi. Da un lato la voce raschiante dell’uomo che fuma la sigaretta, dall’altro quella di un’altra donna, adulta, il cui tono è aspro, duro, quasi a rinnegare il timbro femminile e materno che ancora se ne coglie. In mezzo il gemito teso, tremolante, che viene dalla ragazza dalla mano macchiata, e, infine, un singhiozzo, un pianto sommesso, sussurrato.
– Smettetela! Entrambi.
E ancora il silenzio cala sulla stanza. È vecchia l’ultima voce che ha parlato. Stanca ma ancora possente, il tono di chi è abituato a dare ordini, e soprattutto ad essere rispettato.
La stanza resta nel buio di un alone sferico e di una lama di sole e il tempo continua a scorrere pesante, trascinandosi le storie di tutti gli esseri umani che vivono quel presente. Sono le storie di quattro figure, silhouette d’ombra contro il nero dell’estinzione finale.
E’ la notte a scandire il passaggio da un giorno all’altro, ad indicare, come un ticchettio silenzioso, lo scorrere pigro dal passato al futuro, senza neppure giacere nel momento. Non vi è realtà nel presente della stanza e delle quattro figure.
Il buio è ora ovunque, scomparso il raggio di un sole ormai tramontato chissà dove, spento l’alone sferico di una lampadina consumata. Il nero si fa opprimente, avvolge gli oggetti e ogni cosa scompare. Resta solo il freddo di una notte d’autunno in una stanza senza nessun calore se non il respiro convulso di quattro figure. Neppure si scorgono le piccole nubi dei tiepidi aliti e il freddo sembra perdersi nel buio.
Nella stanza si odono i respiri regolari del sonno. Lenti, ritmati sospiri, profondi ansimi delle coscienze sprofondate e dormienti.
– Dormi?
Nessuna risposta.
La voce femminile, delicata esita. La parola sussurrata, quasi troncata per non rompere il ritmo dei sospiri ma incapace di resistere alla curiosità, alla paura del silenzio, all’orrore del vacuo.
– Dormi?
Quanto coraggio per tentare di nuovo, per alzare il tono, per chiedere e nel farlo pretendere.
– Si.
– Scusa. Non volevo svegliarti.
– Non importa.
L’altra voce femminile libera il tono materno, affettuoso, protettivo. Scomparsa è la rabbia, la ferocia di prima, una madre ora al sicuro con i suoi cuccioli.
– Non riesco a dormire.
– Neppure io.
– Che senso ha dormire?
– Abitudine.
– Non ricordo neppure il tempo. Da quanto sono seduta su questa poltrona?
– Dal mio stesso tempo.
– E tu da quanto lo sei?
Silenzio. Un attimo più lungo dei precedenti.
– Non lo so.
– Silenzio! Smettetela voi due. Lasciatemi dormire.
La terza voce. Quasi richiamata nel buio, come un predatore, da un odore, da un sussurro o dal rumore di un gesto sbadato. Cattiva. Pronta a ferire col tono tagliente.
Si ode il solito suono, uno schiocco, la fiamma divampa e la brace si accende. Un’altra sigaretta tributata al dio dell’insonnia. Nella stanza ormai è solo uno il respiro che lentamente pasce nei campi del sogno. Ignaro di una conversazione incomprensibile.
– Voi due donne fate discorsi senza senso.
E la punta della sigaretta si illumina, un punto di luce rosso, violento, rabbioso.
– Rispondi tu allora. Da quanto tempo sei qui.
– Cosa c’entra. Non importa il quanto. Ma il perché.
– E tu le conosci le ragioni?
– Certo. Io le conosco.
– E quali sono?
– Stiamo aspettando.
– Cosa? Cosa stiamo aspettando qui, seduti su queste poltrone da così tanto tempo da non ricordarlo neppure più?!
– Aspettiamo.
– Cosa?
– Nulla. Non c’è nulla da aspettare. E ora chiudete il becco.
Il punto rosso della brace compie un improvviso arco e con un leggero sfrigolio si spegne per terra, forse in una pozza o forse in altro.
Il silenzio ritorna. Un silenzio diverso. Rotto dal respiro lento e regolare di una voce vecchia ma possente che resta, caparbiamente, zitta. E tre altre attendono. Aspettano una parola che quella notte non verrà.
Ogni mattino, in qualunque luogo del mondo, i rumori sono identici, si ripetono in un ciclo convulso e assordante, frenetici picchiettii, accelerate improvvise, sbadigli repressi e rotaie torchiate da ruote metalliche. Suoni riconosciuti, iscritti nello stesso muovere del tempo, come un sinfonico accompagnamento, o forse una trionfale marcia delle prime abbaglianti ore del giorno. Una stonata banda che pomposa annuncia l’arrivo del sole oltre le montagne là in fondo.
Non nella stanza. Lì, circondanti dalle pareti grigie di calcinacci senza intonaco, ogni mattino sono altre le note distorte che s’odono. E sono le striscianti voci, bisbiglianti e fastidiose, che accompagnano il feretro nero verso la sepoltura di ogni illusione.
– Basta! Non ne posso più.
Uno sfogo ripetuto ogni singolo giorno, all’accendersi metodico della lampadina e del suo alone opaco, ripetuto ancora all’arrivo del raggio del sole che fende l’aria e la polvere che vi ristagna.
Ma nessuno sembra ascoltare la lamentela. Né dentro la stanza, né fuori la stanza.
– Voglio andarmene!
E’ l’uomo delle sigarette a urlare la sua frustrazione. Intorno giace un silenzio ovattato di indifferenza.
– Fatemi uscire. Arrivate. Voglio andarmene!
– E dove?
L’altro uomo. Il vecchio. Poche sono le sue parole all’interno della stanza, ma pesanti come macigni condotti in cima ad un monte. Infinite volte.
– Ovunque.
– Non esiste un luogo simile.
– Qualunque posto. Uno, dannazione!, va bene l’altro. Tutto ma non qui.
– Perché non qui?
– Perché qui non vi è nulla. Sono rinchiuso con voi. Dentro queste quattro mura.
– E cosa ti angoscia di questo?
– Loro! Io so che mi sentono. Mi vedono. Loro mi osservano. Stanno aspettando. Arriveranno.
– Chi sono Loro?
– Non lo so. Cazzo! Non lo so. Ma so che apriranno al porta!
– Quale porta?
– Quella porta!
Un gesto, deciso. Indica una direzione. Un punto preciso racchiuso dalle mura della stanza. Si voltano. Tutti gli sguardi seguono il dito teso, forse un po’ tremante, che indica. Là.
Gli occhi sono puntati. Si socchiudono nella speranza di mettere a fuoco, di scorgere meglio. Di vedere. Ma là solo nero. Buio. Nessuna porta.
Il braccio teso si affloscia, cade pesantemente sul bracciolo della poltrona, come esangue. E la voce rabbiosa si spegne in un’eco che si distorce.
– La porta. La porta. Là. Porta.
– Deve esserci la porta!
Voce di ragazza, in perenne bilico tra l’essere bambina e giovane donna. Decisa. Lei sa che nulla può essere così insensato da non poter essere compreso.
– Ogni stanza ha una porta! Anche questa deve averla. Siamo noi a non vederla. Solo per questo maledetto buio che ci avvolge.
Certezze. Certezze che ogni cosa nel mondo debba avere una sua ragione. E una sua sede.
Stranamente l’altra voce femminile materna tace, non supporta il pensiero espresso. Come se fosse un bambinesco capriccio a cui non dar peso.
– No. Nessuna porta. Non vi sono vie d’uscita a questa stanza. Ciò che ci circonda è tutto ciò che per noi esiste. Non vi è un al di là, un oltre.
– E che ne sai tu?!!! Parli ora, ma cosa ne sai?!
– Sono vecchio. Io ho vissuto tutta la mia vita dentro questa stanza e so che ora che sto per morire non vi è nulla oltre. Se anche ci osservano, sono indifferenti alla nostra sorte.
– Come puoi esserne certo?
L’altra voce femminile. Non c’è curiosità nella sua voce. Piuttosto c’è paura. Paura della risposta che sa aver creato con quella domanda. Paura di conoscere già la risposta.
– Perché io ero qui quando voi siete arrivati…
Silenzio.
– Perché voi, come me, siete nati qui dentro.
Silenzio.
– E qui siete condannati.
Silenzio.
– A morirvi.
Le ore scorrono. L’una dopo l’altra. Meticolose. Puntuali, pignole. In ogni luogo esse eseguono il loro caparbio compito; artigiane laboriose, tessitrici instancabili della trama del tempo. Ma ogni ora è diversa, unicità irripetibile di un fenomeno di distorsione.
Ogni ora è difforme a se stessa infinte volte. Esiste miriadi di volte. Si ripete differentemente nei singoli soggetti che in essa vivono, nascono e muoiono.
Ogni ora si dilata, si restringe, trascorre in un veloce momento o in stasi eterna. L’identica ora vive gli irriducibili universi delle creature viventi. E l’ora esiste solo in questa frammentazione di pulviscoli, di uomini. Solo in essi, solo nei viventi, l’ora, il tempo, trovano senso. Trovano esistenza.
Oggettività che esiste solo nel relativismo della singolarità. Paradosso. Ennesimo paradosso.
Quell’ora visse nei mondi distanti degli esseri nella stanza.
– Laggiù!
Un urlo improvviso. Rotta la sonnolenza della stanza, delle poltrone. E le altre figure sedute s’agitano. E’ la donna ad urlare.
– Laggiù!
Sembra esserci follia nascosta nella sua voce. Come se avesse perso il potere sui luoghi in cui la sua mente si spinge, trova rifugio. Come se fosse sull’orlo della deriva.
– Laggiù!
O forse v’è altro nel grido. Nascosto in fondo ad esso. Quasi camuffato. Ma che si intuisce. Un pensiero molesto che emerge, che si tenta di scacciare. Vanamente.
– Laggiù!
E se questo pensiero fosse la speranza? Speranza di dare senso. Di trovare una ragione. Non sarebbe il più pericoloso tra i pensieri? Non sarebbe allora davvero bordo di follia?
– Laggiù!
– Cosa?!!!
– Cosa hai visto?
– Dove?
Le altre tre voci rispondono. Irata. Compassionevole. E pratica. Tutte però in egual misura curiose.
– Un’ombra! Si è mossa un’ombra laggiù!
La luce riflessa dalla lampadina che pende malamente dal soffitto sembra farsi più fioca. E il nero intorno più scuro, più opprimente. Neppure la daga di luce dalla finestra giunge a donare sollievo.
– Si. L’ho vista. Si è mossa. Si è spostata. Uno scatto. Ma l’ho vista.
– Sono Loro! Ve l’avevo detto.
– Stava venendo qui. Da noi? Cosa vuole?
– Sei sicura?
Ancora le tre voci. Medesimo l’ordine. Il fanatismo dell’uomo con la sigaretta. Il terrore della ragazza. Il pragmatismo del vecchio. E a innescare le voci diverse l’incredulità della donna, che è costretta a credere a ciò che non vorrebbe credere. L’ombra. Nel nero.
– Stavo fissando il nulla. Stavo aspettando che l’ora passasse. E l’ho vista. Un guizzo. Un pezzo di nero che s’è mosso nel buio dello sfondo.
– Ci osservano! Aspettano il momento. Sarò pronto. Che forma aveva?
– Che forma aveva? Era cattiva? Perché è qui?
– Che forma aveva? Cosa importa? Dove si è spostata?
Domande. Il desiderio di conoscere. Di assoggettare alla propria mente e inglobare, dominare nel proprio mondo. Trasformare ciò che sta oltre, oscuro, in un pezzo del dominio, conquistarlo ed annetterlo al regno della propria conoscenza. Rendendolo innocuo.
E’ la donna a dover dare risposte che non ha a domande che vorrebbe essa stessa urlare.
– Non lo so. Era nero. Si è mosso, di là mi sembra. E’ stato un attimo.
Senza conoscenza non vi è controllo. E ogni cosa resta semplicemente pericolosa.
– Manca poco! Me lo sento. Stanno arrivando! Mi libereranno.
– Non voglio! Ho paura! Chi sono? Dove ci portano?
– Da nessuna parte. Non ci porteranno da nessuna parte. Noi siamo indispensabili per loro.
Qualcosa attraversa la stanza, non un’ombra. Una sensazione. Un brivido che corre lungo le schiene delle poltrone. E di chi vi è seduto. Nelle parole del vecchio s’annida un sospetto. Un covo di serpi ripugnanti nascosto in fondo ad un pozzo. Nero. Profondo. Inatteso.
La donna non replica. E’ cambiato qualcosa nel gioco delle parti. Non è più lei, con lo sguardo fugace dato all’ombra che guizzava, a conoscere qualcosa da svelare agli altri. No. E’ ancora una volta il vecchio. Nelle sue parole vi è un’antica saggezza che sembra emergere lentamente. Svelarsi pudica, donandosi agli altri come un’amante affettuosa.
– Che cazzo stai dicendo?
Il tono dell’uomo, la sua voce raschiata dal fumo di innumerevoli sigarette aspirate con avidità e rabbia, dice più che la sua domanda e dice ciò che anche le donne vogliono sapere. Che significa?
– Ma non lo avete ancora capito?
– No! Sapientone spiegati.
– Smettila con questo tono! Lascialo parlare.
Sembra attendere il vecchio. Come se volesse svolgere il suo compito. Creare tensione. Pathos. Come se in questo atteggiamento vi fosse già la risposta alle domande. Silenzio. E la carica di tensione si leva in un silenzioso grido di aiuto. Gli altri attendono. Seduti sulle poltrone. Fissando.
– Alzati.
E’ improvvisa la risposta del vecchio. Tagliente e diretta. Un ordine. Un invito diretto all’uomo che fuma. E Alle due donne. E a se stesso.
– Alzati e vai a vedere dove s’è nascosta l’ombra.
– Dimmelo tu, vecchio!
– Io? Io non lo so. Come posso saperlo?
– Sei tu che fa quello che conosce ogni cosa.
– Io non so nulla. L’avevo già detto.
– Tu avevi detto di sapere perché eri vecchio.
– Io conosco solo ciò che ho visto nei miei anni qui. Seduto qui, su questa poltrona.
– E cosa cazzo hai visto?
– Te l’ho già detto: niente.
– Perché noi siamo loro indispensabili?
La donna ripete la domanda e interrompe la catena di incomunicabilità fra i due uomini.
– Perché? Semplice. Alzati. E vai a vedere in quel punto, là dove è sparita l’ombra. Vai a vedere dove è andata.
– Non posso.
– Perché non puoi?
– Perché non posso. Non ne sono in grado.
– Eggià. Non ne sei in grado. Nemmeno io. Nemmeno voi. Nessuno di noi è in grado di alzarsi da queste dannate poltrone.
– Ma le poltrone sono la nostra casa. La nostra vita.
La fanciulla, la cui ingenuità a volte ha il potere di donare infinita tristezza. O straripante rabbia.
– E che diamine c’entra questo con il fatto che siamo indispensabili a loro?
L’uomo con la sigaretta. Non capisce. Non vuole capire.
– Tu l’hai compreso, vero?
Il vecchio, quasi con un sorriso complice, verso la donna.
– Si. Ho capito.
– Ne ero certo.
– Che cazzo hai capito?
Nessuno risponde.
– Rispondi cazzo!
Silenzio.
– Rispondi!!!
E questa volta a rispondere è solo il pianto spaventato della fanciulla.
Anche lei ha compreso. E piange.
Un istante come tanti. Una conversazione come tante. Nella stanza gli istanti si legano fra loro in una collosa epifania di nulla.
Un momento.
– Ricordo quella volta..
– Si.. anche io la ricordo.
– Ma è la stessa?
– Che altra?
Un momento.
– Dicevo, ricordo quella volta…
– Mentre camminavi.
– Ma dove?
– O eri fermo?
Un momento.
– Quella volta in cui osservavo.
– Ah già! Il mondo.
– Le mani.
– Le stelle.
Un momento.
– In cui osservavo questo tavolino.
– Anch’io lo guardo ogni tanto.
– E’ brutto.
– E questi bicchieri. Tutti scompaginati.
Un momento.
– E sul tavolino vedevo l’alone della lampadina.
– Ma chi l’accende?
– Ogni giorno.
– Tutte le mattine.
Un momento.
– Fermo. Ma nei bicchieri il liquido sembrava danzare.
– Come in un teatro di danza.
– Come le foglie al vento.
– Terribile questo vino!
Un momento.
– E nelle onde leggere sulla superficie vedevo altro.
– Il mare! Che bello dev’essere il mare.
– Quanti visi e quanti sorrisi sono racchiusi nella memoria.
– Ma non ci potevano dare un vino migliore?
Un momento.
– Per un po’ l’ho guardato.
– Il tempo scorre lento dentro questa stanza.
– Sei tu che non sai vivere la giornata.
– A proposito. Che ore sono?
Un momento.
– Poi nel riflesso ho capito cosa stavo guardando.
– La mente, quale potere.
– Una volta mi ricordo che anche io…
– Allora non sapete proprio che ore sono?
Un momento.
– E ho avuto paura.
Un momento. Più lento.
– Di cosa hai avuto paura?
– Perché hai avuto paura?
– Che ci hai visto nel riflesso?
L’ultimo momento.
– Vi ho visto voi.
E il coro tace.
Un ticchettio. Una goccia cade lentamente e tintinna su una lastra metallica nascosta chissà dove nel buio. In fondo alla stanza, oltre i confini della luce, nella periferia di un impero in decadenza, pallido ricordo di un potere sconfitto, un suono si ripete. Ritmico. Demenza ripetuta. Due occhi fissano il nero là in fondo cercando di scorgervi qualcosa, si socchiudono, scrutano ma ciò che resta è solo un’oscurità velata, ed oltre il suono. Ripetuto. Assillante.
Nella stanza ristagna un odore di pioggia. Sale improvviso alle narici lasciando che la memoria torni a paesaggi antichi. E vi si allontani. Timorosa. Spaventata.
– Sta piovendo.
Non una domanda. Una constatazione. E nessuna risposta.
Le quattro figure parzialmente racchiuse nell’alone della lampadina che cade dal soffitto, stanno immobili. Ferme. Come se la pioggia fosse un evento da celebrare. Da ricordare. Il segno di una realtà che esiste, di una ciclicità persistente. Ostinata, aldilà dell’immobilità dell’uomo.
Silenziose le figure stanno in ascolto. Nessun rumore se non il ritmico, cadenzato cadere di una singola, insistente, goccia nel nero in fondo alla stanza. S’infrange su una lastra di metallo e produce un suono prolungato, dilatato che sale lentamente verso un climax e poi si spegne, subito dopo, improvvisamente. E nell’aria rimane solo il sospetto del suo passaggio. Ricordo o immaginazione?
Una sola goccia che precipita rumorosa, martellante, che tiene col fiato sospeso, in attesa del suo ritorno, pochi attimi dopo. Essa annuncia se stessa in una ritorsione incalzante. Asfissiante. E’ la pioggia che benedice la stanza.
– Si. Sta piovendo a dirotto.
E la singola goccia cade. E il rumore attraversa la stanza. Dietro di sé un’aura di speranza. Un invito e un messaggio: il suo prossimo ritorno.
– E’ tanto che non pioveva così tanto. Si. Tanto tempo.
La promessa è mantenuta. Una nuova goccia. Sembra di vederla nel nero. Lucente, cristallina, pulita e trasparente. Pigra si stacca dal soffitto della stanza e scivola nel nulla addomesticata e s’immola sul grigio rugginoso della lamiera gettata a caso in un angolo. E rivela una nuova se stessa. Messia di una religione che salva.
– Che bello ascoltare il suono della pioggia.
Tlack. Un’altra goccia. Tlack. Un’altra goccia. Convulsamente e lentamente. Ripetutamente.
E le figure rimangono come incantate. Sedute sulle loro poltrone.
La donna sospira.
La fanciulla si rannicchia. E sorride.
L’uomo si accende una sigaretta e aspira con voluttà il fumo denso e azzurrognolo.
Il vecchio prende un bicchiere dal tavolino. Beve un sorso del liquido denso e amaranto che vi ristagna. Profumato. Alza il bicchiere come a voler vedere nel riflesso della luce altri volti. Antichi e perduti volti.
E’ un momento.
Un gesto improvviso.
Inaspettato.
Violentemente lo scaglia. Nel nero là in fondo. Oltre il dominio della luce. Nell’angolo più lontano. In quell’angolo.
S’infrange il bicchiere sulla lamiera metallica. Colpisce la superficie rugginosa, ramata nel buio. Come una goccia, immensa, vetrosa. Finale. Definitiva. Mortale. Ultima.
Sobbalzano le altre tre figure. Cade la sigaretta e identico è lo stupore.
Cala il silenzio nella stanza. E l’attesa. Di un’altra goccia.
L’attesa di un nuovo suono, di un tlack, dell’annunciazione. Ripetuta.
Ma nulla arriva. Nessun suono riconosciuto. E resta solo il silenzio. E l’attesa. Frustrata. Inutile.
– Perché l’hai fatto?
– Stava piovendo così bene.
– Sei impazzito?!
Il vecchio risponde. E nelle sue parole c’è una saggezza antica che non può essere compresa. Sembra ormai solo follia.
– No. Non stava piovendo.
E sul tavolo restano ora solo tre bicchieri.
CONTINUA…
Racconto pubblicato nell’antologia “Frammenti di una rosa quantica” – Kipple Officina Libraria, 2008.

Alex Tonelli è nato in riva all’Adda nel 1977 e si è laureato in Filosofia a Milano con una tesi contro il libero arbitrio. Connettivista da sempre, ha curato la rubrica Ermetica Ermenuetica sul bollettino del Movimento NeXT e la raccolta di poeti connettivisti “Concetti Spaziali, Oltre” (Kipple Officina Libraria). È presente nelle antologie “Frammenti di una Rosa Quantica” (Kipple Officina Libraria), “Nuove Eterotopie” (Delos Libri) e “La prima frontiera” (Kipple Officina Libraria) e dal 2015 è il curatore della collana di poesia VersiGuasti per la Kipple Officina Libraria. Ha pubblicato una silloge di poesie dal titolo “Oltremuro” (Kipple Officina Libraria). Attualmente vive a Trieste.